Una ripartenza necessaria e senza speranza

Per il nostro speciale “Il Molise dopo il Coronavirus” riceviamo e pubblichiamo un contributo di Norberto Lombardi, Storico dell’emigrazione
- L’altra ripartenza
L’ho vissuta un’altra ripartenza. Ero piccolo, ma me la ricordo abbastanza bene e poi l’ho ricostruita nel corso del tempo, aggiungendo tassello a tassello. Era quella del dopoguerra, quando si trattò di far fronte ai disastri di una guerra non metaforica, come quella del coronavirus, e soprattutto di dare risposte a milioni di italiani che volevano lasciarsi alle spalle non solo le devastazioni e i lutti di anni di conflitto, ma anche le ristrettezze e i disagi di una condizione di arretratezza diffusa e talvolta estrema.
Il Molise entrava in quella fase con il maggior carico di popolazione che abbia registrato nella sua storia – oltre 400.000 residenti – e con un tasso di ruralità della sua popolazione attiva – l’80,1% – che non si discostava da quello che alcuni anni prima le avevano fatto meritare l’enfatico riconoscimento di “provincia ruralissima”.
Del clima e dei problemi di quella lontana ripartenza ho potuto vivere due dimensioni, quella paesana della realtà molisana in cui vivevo e quella urbana di Roma e della sua fascia litoranea per via della permanenza in collegio ad Ostia negli anni cruciali della Costituente e delle elezioni del 18 aprile del ’48, che fecero da spartiacque per la storia italiana successiva.
La dimensione paesana era fervida, operosa ma povera e ancora deprivata di cose essenziali, come liberarsi dalla fame, potersi curare dalle malattie, avere sul piano formativo qualcosa di più dell’alfabetizzazione, allargare il cordone soffocante delle convenzioni sociali. Quella urbana, almeno negli strati popolari e picolo-impiegatizi, era anch’essa priva di cose importanti, come il cibo le case il lavoro, e conosceva tensioni politiche e sociali molto aspre, ma era percorsa da fremiti e passioni civili autentici e intensi, che trovavano eco nelle espressioni artistiche del momento, il cinema, la letteratura, la pittura.
Di quella ripartenza ricordo, in particolare, la povertà diffusa e la fame vera di tante persone, in particolare delle famiglie dei contadini, degli artigiani poveri e dei giornalieri. Eppure, nella loro tensione alla sopravvivenza e anche nella loro rabbia si coglieva quasi sempre un elemento di speranza, la convinzione che con lo sforzo personale e con la solidarietà collettiva si potesse migliorare, andare avanti, agguantare un futuro diverso.
- Un futuro senza speranza?
Ecco, la speranza e un senso positivo del futuro. Queste mi sembrano le maggiori differenze tra allora e oggi. Già alla fine dello scorso anno, prima ancora dello shock pandemico, in premessa al mio libro sulla crisi del regionalismo molisano, ho scritto: «L’ostacolo più alto è il forte svuotamento di spirito civile che si percepisce, di voglia di impegnarsi, di speranza di farcela, che aleggia diffusamente e che viene quotidianamente amplificata dalla pratica ormai dilagante dei social».
Lo riporto solo per dire che si tratta di una sensazione radicata e non nuova. La novità di oggi, semmai, è nel fatto che quella che nell’altra ripartenza sembrava una inseparabile endiadi – speranza e futuro- oggi sembra essere diventata una contraddizione da interpretare. Anche se non per un impulso di speranza, la spallata dell’epidemia ci ha costretti a pensare di nuovo al futuro, a quel futuro che avevamo avvolto di ombra e di inquietudine e al quale ci stavamo rassegnando come a un destino. Un destino sostanzialmente mediocre: piccoli passi possibili in condizioni date.
In questo futuro senza speranza che s’intravede, questa contraddizione sorprende: più è flebile la speranza di poter costruire una realtà qualitativamente diversa sulle macerie sociali, economiche e relazionali che si stanno accumulando, più si rafforza la necessità, non fosse altro che per bisogno di tutela e di sopravvivenza, di impegnarsi per ridefinire i modelli di relazione sociale e le compatibilità con l’ambiente e con il sistema di produzione di beni e servizi.
Confesso che il mantra “niente sarà come prima” non mi aiuta molto a capire come le cose andranno realmente. Non c’è dubbio che lo tsunami della pandemia abbia interrotto e travolto le vecchie strade e che per potere andare avanti occorra costruirne una nuova.
Tuttavia, non sono certo che l’invocata pedagogia del Covid-19, che pure ci ha messo con le spalle al muro rispetto ai nostri tradizionali comportamenti e al senso di onnipotenza scientifica e tecnologica che ci aveva invaso, abbia finalmente chiarito gli inganni agli occhi dei più e portato allo scoperto le soperchierie che stavamo commettendo verso l’ambiente, le risorse, i diritti umani e l’equità delle scelte sul piano sociale. Soprattutto non sono certo che l’angoscia che viviamo in questi mesi si trasformi linearmente da timore per la nostra sopravvivenza, qui ed oggi, a consapevolezza che stiamo bruciando il futuro di molte generazioni che ci seguiranno.
Intanto, si tratta di vedere se quell’angoscia, una volta schiarita a nuttata, si traduca in un diverso modo di rapportarsi alle cose e al futuro o non inneschi piuttosto un’incontenibile voglia di “ritorno alla normalità”, alimentando nuove forme di avidità e di ebbrezza per il consumo: consumo di tempo, di beni, di risorse, di ambiente, consumo di futuro, appunto.
Non parlo naturalmente delle minoranze riflessive e di quelle etiche, più propense ad assumere il limite come un dato fondamentale della realtà che viviamo e fors’anche come un valore, ma delle grandi tendenze popolari, quotidianamente sagomate e sospinte dai sistemi di comunicazione.
Per questo credo che non cambierà molto lo schema che finora abbiamo conosciuto, quello di un rapporto dialettico tra le minoranze critiche ed etiche impegnate a demistificare messaggi consumistici e campagne populistiche, oltre che a suggerire riferimenti valoriali, e una larga massa di persone che nelle forme e con le motivazioni più diverse soggiacciono alle leggi del consumo e ne diventano interpreti nella ordinaria quotidianità.
- La qualità è il vero discrimine di una nuova sanità
Per essere sincero, non sono nemmeno sicuro che le cose siano tranquille anche in quello che considero il mio campo politico e culturale. Sento dire, ad esempio: «Ecco, finalmente i nodi sono arrivati al pettine e tutti hanno capito, a loro spese, che il nodo tra la sanità pubblica e quella privata vada sciolto a favore della prima».
Non c’è dubbio che la pandemia abbia reso più chiara l’alternativa, forse l’abbia addirittura drammatizzata. Per la verità, la convinzione che solo la sanità pubblica sia in grado di concretizzare in termini universalistici il diritto costituzionale alla salute c’era già prima.
Le questioni vere riguardavano la progressiva diminuzione delle risorse destinate nel complesso alla tutela efficace e paritaria della salute dei cittadini e il discutibile rapporto tra i due settori, oltre all’atavica frugalità del sostegno alla ricerca scientifica. Non c’è nulla che faccia pensare che la corposità degli interessi che hanno sospinto la sanità privata (si pensi alla Lombardia e al Molise) sia diluita dal coronavirus. Resteranno lì e bisognerà continuare a farci i conti, magari con argomentazioni che la pandemia ha reso più credibili.
Ma al di là di questo, c’è un problema di qualità e di visione che stenta a farsi strada e che rischia di essere accantonato dalle rivendicazioni identitarie. Da noi, la pandemia è stata utilizzata per riaffermare la priorità degli ospedali, chiedendo a gran voce la riapertura di quelli chiusi.
Senza entrare nel merito dei singoli casi, se c’è una drammatica evidenza nell’esperienza che stiamo vivendo è che l’ospedalizzazione dell’emergenza e la debolezza di una rete territoriale con forti funzioni di prevenzione e di filtro possono diventare a loro volta fattori di rischio e, addirittura, di letalità. Considerando che molti dei casi di positività riscontrati in Molise provengono dal modo come gli ambulatori e i servizi del 118 hanno operato, vuol dire che siamo ancora molto lontani da un sistema di prevenzione e di cura degne di questo nome.
Si rischia di commettere gli stessi errori degli anni Ottanta, quando la sanità molisana fu costruita intorno agli ospedali, con rare (e apprezzabili) eccezioni di sevizi sul territorio. Allora, almeno, eravamo una delle regioni con meno posti letto per abitante, ma oggi?
Non mi basta, allora, essere intruppato nello schieramento dei “pubblicisti” per sentirmi tranquillo per il futuro. Se la sanità pubblica deve diventare una volta per tutte l’asse della tutela della salute dei molisani, dovremmo capire qual è il suo programma di risanamento e di riforma, soprattutto sui temi decisivi della prevenzione e delle reti territoriali.
Ho motivo di non essere tranquillo, perché non da oggi sono convinto che la sanità pubblica molisana si trascini il peso di non pochi errori. Tanto per capirci, gli sdoppiamenti di reparti, i primariati ad personam, l’allontanamento di specialisti di valore a tutela di carriere “interne”, gli intrecci con un’improbabile facoltà di medicina, e così via.
Se non li riconosce dicendo che la colpa è sempre e solo degli altri, la sua sacrosanta battaglia rischia di non vincerla mai. Allora, anche in questo campo, come siamo messi per il dopo coronavirus? Non credo che basteranno i proclami né i buoni propositi, solo la qualità delle scelte di riorganizzazione e i fatti ci diranno se imboccheremo veramente una strada nuova.
- Più tecnologia e ricerca nella formazione
Un ultimo esempio voglio farlo nel campo della formazione. La didattica a distanza è stata la risposta data al trauma che l’epidemia ha inferto al percorso formativo. Al punto da diventare elemento di valutazione del profitto dei ragazzi. E’ certamente apprezzabile la prontezza della reazione di istituti e insegnanti, anche se, purtroppo, l’esclusione di oltre un terzo delle famiglie meridionali dalla pratica tecnologica ne limita le ricadute.
Ma al di là di questo, sento persone anche avvedute dichiarare che non vedono l’ora che questa parentesi di didattica acrobatica e artificiosa finisca e si torni all’abbraccio corale e caciaroso nelle classi. Ora, non oso nemmeno pensare che si possa fare a meno del rapporto diretto e personale dell’insegnante con gli alunni, ma trovo allarmante che l’applicazione della tecnologia alla formazione possa essere considerata una parentesi da chiudere prima possibile.
Credo, invece, che da questa esperienza bisognerebbe trarre nel campo della formazione, come in quello della sanità, una buona e forse addirittura ovvia lezione: le tecnologie informatiche, se dosate e applicate in modo proprio, possono aiutare a rinnovare la didattica, a dare respiro e velocità all’acquisizione delle conoscenze, ad ampliare le relazioni e i contatti dei giovani, che già stanno attraversando un mondo ipertecnologico. Insomma, un innesto innovativo e dinamico e di potenziamento del percorso formativo, non solo una condizione di necessità da lasciarsi alle spalle in nome di un’agognata normalizzazione.
Così, tanto per dirla con una sola battuta, è sicuro che l’esperienza di lavoro a distanza sia solo un rimedio di emergenza rispetto a quello dietro una scrivania? Non potrebbe essere anche un modo di riconsiderare la finta legalità del timbro del cartellino e spostare il fulcro del rapporto di lavoro sulla produttività e sulla verifica dei risultati?
Tornando al delicato ambito della formazione, credo che il colpo dato alla nostra supponenza di avere una cassetta degli attrezzi buona per ogni evenienza, di salute e non, ci abbia fatto riflettere su quanto valore anche pratico abbia la ricerca in generale e quella scientifica in particolare.
Per questo, non posso fare a meno di pensare che forse con la più importante istituzione di formazione e ricerca che vi è in Molise, l’università, abbiamo sciupato un’occasione fondamentale, diluendo l’iniziale impostazione centrata su corsi caratterizzanti rispetto al profilo del territorio e alla formazione di professioni innovative, “meridionalizzando” le ulteriori articolazioni formative, cedendo alla dispersione localistica e indulgendo ad una didattica tradizionale, non sempre innervata appunto nella ricerca.
Dopo il coronavirus, ci sarà non dico la possibilità di rovesciare un’impostazione ormai consolidata, ma almeno una consapevole virata che possa assumere la consistenza di un’autoriforma scientifica, didattica e organizzativa?
Mi rendo conto che sarebbe meno complicato rispondere a questi interrogativi se li inquadrassimo in un chiaro confronto sul tipo di sviluppo verso il quale orientare gli sforzi di ripresa. Un confronto declinato non con astratte declamazioni progressive o prediche eticizzanti, ma sulla base di un concreto esame delle forze, delle risorse, degli strumenti, dei tempi necessari quantomeno per capire se questo diverso modello sia realistico nel quadro istituzionale e amministrativo attuale e se sia addirittura possibile nel contesto delle condizioni generali e locali che si profilano.
Finora, gli enormi sforzi che si stanno preparando e compiendo a livello nazionale ed europeo vanno tutti nel senso del sostegno dell’esistente e del rilancio delle attività investite dalla recessione, con l’eccezione di qualche vago accenno a incursioni negli investimenti tecnologici e green. Ci saranno concretamente spazi per una linea alternativa, quella di cui l’Italia appenninica e le zone marginali, come la nostra, hanno bisogno per poter ripartire veramente?
Insomma, niente è scontato. Vedremo. Intanto, non sarebbe poco acquisire un metodo di analisi critica di quello che sta accadendo intorno a noi e soprattutto di quello che potremo concretamente fare per non eludere il senso di questa terribile lezione.
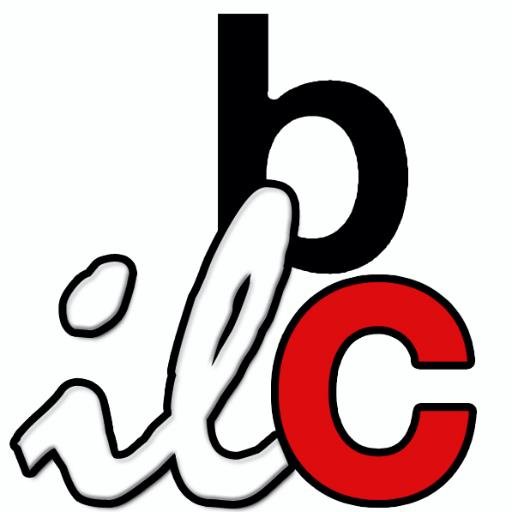
Redazione1592 Posts











0 Comments