Cosa significa andare al mare per un filosofo

Quando l’accademico diventa bagnino non rinuncia a guardare i bagnanti con gli occhi di Sartre, Marx e Bergson. Perché il mare e la spiaggia sono luoghi di anarchia. E noi siamo l’unica risibile ma rispettata parvenza di ordine
<<Attento>>, mi disse Carla , «ché la stagione dà dipendenza». Era l’estate in cui – a luglio – avrei preso due giorni liberi dal lavoro per andarmi a laureare in filosofia contemporanea. Lei era una signora sulla cinquantina, faceva la barista del chiosco sopra la spiaggia. Non sapevo ancora che aveva ragione. Così come non sapevo che ci sono molti tipi di “stagione”.
Io sono un assistente bagnanti, e come tale – in virtù del brevetto – godo di alcune tutele che molti compagni stagionali possono solo sognare. Per molti di loro, noi del salvataggio siamo dei veri e propri privilegiati, detti anche gli “statali”, come mi apostrofarono affettuosamente due cari amici (bagnini di terra, con cui ho lavorato per anni in una spiaggia “vip”), dopo che una sera, arrivate le sette, dissi a una signora un po’ paranoica che lamentava un leggero giramento di testa che o le chiamavo un’ambulanza, o si metteva il cuore in pace, perché io avevo finito il turno e dovevo andare a casa.
La mia stagione – vuoi perché “privilegiato”, vuoi perché ormai ci ho fatto il callo – è diversa da quella del lavapiatti bengalese o dell’aiuto-cuoco rumeno, che lavorano sottopagati quattordici ore al giorno; è diversa anche da quella della ragazze del night club, dei camerieri, delle commesse del supermarket e dei manutentori delle spiagge. Nonostante tutta la fatica, lo stress, il caldo e l’incombente momento in cui potrei trovarmi ad avere la vita di una persona tra le mani, devo ammetterlo, io ci sono affezionato.
Essere sguardo, essere squadra
Il mare, la spiaggia, sono luoghi di anarchia. La gente ci viene a passare qualche giorno o settimana, per poi scomparire: alcuni – gli anziani – sono spaesati, altri – gli arricchiti – sono arroganti e rompipalle, altri ancora – i giovani in festa – sono ubriachi e fuori controllo. Tutto è grottesco, parodistico, una caricatura.
I giovani tedeschi e austriaci, a inizio stagione, si muovono tradizionalmente in massa verso la cittadina dell’alto Adriatico dove lavoro, per la festa della Pentecoste. Ogni anno il popolo più civile del mondo dà prova della propria “superiorità” morale mettendo a ferro e fuoco la città. Memorabile fu il giovane tedesco che si arrampicò in cima alla gru di un condominio in costruzione e dovette essere tirato giù dai vigili del fuoco perché, nello sforzo della scalata, aveva smaltito la sbronza e non aveva più il coraggio di scendere.
In questo luogo di anarchia, la spiaggia, noi “bagnini” siamo l’unica risibile, ma curiosamente rispettata, parvenza di ordine. Dopo molti anni che faccio questo mestiere ho ancora delle difficoltà a trattenere un sorriso quando vedo che i turisti ci prendono sul serio, che i bambini ci salutano come se fossimo persone importanti, o che il bengalese abusivo che ha trovato un cellulare in terra sente il bisogno di informarmi, mentre se lo sta intascando, che non la ha rubato.
Il mio posto di lavoro è una torretta di un metro per un metro, da cui vedo tutti e tutto. Ci passo otto ore al giorno: è la mia casa, la mia prigione, un’estensione del mio corpo. Vedere – e farmi vedere – sono il novanta per cento del mio lavoro. In tutti questi anni trascorsi sul quel “trespolo”, che ha le fattezze di un vero e proprio totem eretto in mezzo a un deserto uniforme sovrappopolato di persone e ombrelloni, ho avuto modo di provare infinite volte in prima persona un’esperienza che avevo approfondito teoricamente durante il primo seminario che ho tenuto all’università quando ero dottorando.
L’esperienza della torretta mi ha dato modo di riflettere (dopo Sartre e Lacan) sullo scarto, sulla frattura, che c’è tra l’occhio – inteso come l’agente della visione, dello spiare al limite – e lo sguardo inteso come l’oggetto che io sono negli occhi degli altri.
L’altro giorno c’era una bella coppia di giovani stranieri che, dopo aver fatto l’amore in acqua, approfittando della poca gente in spiaggia in quel momento, si era fatta venire una mezza voglia di proseguire il romantico accoppiamento anche sulla riva. A tratti mi guardavano, come per sincerarsi che non li vedessi, e ogni volta che voltavo lo sguardo verso di loro (beninteso, io li vedevo sempre… era solo il mio sguardo che proiettavo su di loro attraverso un movimento del capo), fingevano la più totale indifferenza. Così, quando mi è parso che gli anziani che si trovavano a una ventina di metri da loro iniziassero a inquietarsi, mi è bastato scendere dalla torretta e camminare verso la giovane coppia per far sì che i due desistessero dal loro pur nobile intento copulatorio. Cosa volete, le giornate sono lunghe e in spiaggia ci divertiamo con poco…
Dico “ci divertiamo” perché, diversamente da altri lavori stagionali, spesso noi del salvataggio lavoriamo in squadre di persone che – complice la crisi, che non fa esattamente pullulare le opportunità di lavoro – negli anni imparano a conoscersi e a volersi bene. Si tratta di un fatto abbastanza raro per il mondo della stagione, dove ormai, come nel resto del mondo del lavoro, vige il principio divide et impera, attraverso cui “i padroni” (perché non chiamarli col loro nome?) fomentano e sfruttano a proprio vantaggio la guerra tra poveri.
Passando ore e ore, giorni e giorni, insieme, sotto il sole, il tuo vicino di torretta diventa, per quei cinque mesi, la persona che conosci meglio, e che vedi di più, tra tutte quelle della tua vita (mogli e figli compresi). Conosci il suo stato di salute, le altalene della sua libido, cosa mangia per pranzo. Ci si scambia sigarette, calzini quando viene il brutto tempo, posate, cibo, e le più diverse impressioni sul mondo e sulle cose. Come in una monca guerra di trincea, apparentemente senza “nemico”, in cui attendi solo il momento in cui potrai andare a casa.
Nel nostro lavoro il concetto di “squadra”, di “gruppo”, di solidarietà tra i lavoratori, esiste fuori da ogni logica neoliberale, esiste da prima: è una necessità. Sia perché sai bene che da un momento all’altro potrebbe capitarti di dover fare insieme qualcosa di molto angosciante, come “pompare” (questo è il termine gergale che usiamo) qualcuno che è annegato o è andato in arresto cardiaco; sia perché, per la struttura stessa del nostro lavoro, salvo che per alcuni poveri di spirito (che chiamiamo “infami”), non esistono prospettive di carriera o di “scalata” aziendale.
Nel nostro lavoro può ancora succedere che un “infame”, diventato capo grazie a questa spiacevole dote, possa essere fatto letteralmente “saltare” grazie a qualcosa che in contesti più grandi ormai è divenuto semplicemente impensabile: un’iniziativa di comune, una presa di posizione dell’intera squadra, che a una voce si esprime per ottenere qualcosa.
Sexo y muerte
Ho passato tutta la giornata in spiaggia. Ora sono a letto, fuori c’è ancora luce. Mentre sprofondo nel dormiveglia il frastuono delle cicale si interrompe, come sempre, salvo che per qualche ritardataria, alle nove e mezzo in punto. Con lo scemare delle voci delle cicale iniziano ad affollarsi le immagini del dormiveglia: un campo blu, il mare che entra ed esce dai miei occhi ogni giorno, come fumo, fa il giro del corpo cavo e poroso, sudato e bruciato, che sono. Nel campo blu si affollano tanti puntini, le teste dei bagnanti che – come i grappoli d’uva dopo una giornata di vendemmia – si ripresentano nel mio mondo onirico, per essere stati troppo guardati durante il giorno.
Il campo si dissolve e si fa strada una giornata di settembre, di sette anni fa, una giornata di burrasca. Arrivo in bicicletta al lavoro, il capo mi raggiunge trafelato: «C’è un corpo sulla riva», spiaggiato al mattino presto, trovato dal custode della spiaggia, nessuno lo ha ancora toccato. Mentre ci affrettiamo verso il corpo, a un certo punto, d’istinto, chiedo al capo se la persona è in fin di vita, e lui: «No no, è un disperso, scomparso ieri in mare nella località balneare al di là della foce».
Al che allora, altrettanto d’istinto gli dico: «Bon, ma se è già morto, perché corriamo?». Raggiungiamo il cadavere, lo giriamo, lo adagiamo su di un lettino: è un giovane uomo croato di trentaquattro anni, del quale poi si saprà che era uscito in mare con le figlie, tornate a riva poco prima che lui fosse inghiottito dal mare in burrasca.
Mentre assistiamo le spoglie al contempo rigide e spugnose del pover’uomo, giungono le autorità. Un ufficiale arrivato per il sopralluogo, osservando il corpo, esclama con un inconfondibile accento meridionale: «Ah, è già arrivato, lo aspettavamo per oggi pomeriggio». Poco più in là, la moglie del corpo – arrivata per il riconoscimento – distrutta, eppure composta nell’automatico gesto del fumo, consuma in un pietrificato silenzio la slava dignità di un dolore inavvicinabile.
Ricordo che quel tragico mattino l’uscita grottesca dell’ufficiale di fronte al cadavere mi fece involontariamente ridere. Mi fece ridere, credo, per la stessa ragione per cui mi è sempre scappato da ridere alle soglie degli incontri erotici occasionali che sono parte integrante della vita di stagione. Forse mi succede perché il riso non è necessariamente l’effetto di una scena comica osservata con sadico distacco, come pensava Bergson, né quel particolare momento di “allegria” in cui, come pensava Lucrezio, guardando il naufragio ben piantati sul promontorio ci si rallegra della propria fortuna, misurandola sulla sventura altrui.
Il riso, al contrario, come diceva Bataille, può essere anche “masochistico”: un qualcosa che entra, che ci risucchia nella scena, come un non-sapere, come il limite di quello che possiamo capire, accettare, tollerare. Esiste anche un riso ebbro di essere nel naufragio, un riso nel terrore, nell’angoscia, nella vertigine: un riso che si scatena e gioca sulle soglie, sul limite tra terra e mare, tra vita e morte, tra il dentro dei pensieri e il fuori dei corpi che, sconosciuti, si intrecciano, si confondono e si disperdono nel caldo e nel sudore.
Gli incontri erotici estivi, seppur nella loro pochezza e fugacità, hanno a volte il pregio di aggirare la doppia maledizione che grava sul nostro contemporaneo rapporto con l’erotismo. Troppo spesso ho l’impressione infatti che esistano solo due modalità dell’incontro erotico: quella istintivo-biologica e quella romantico-fusionale. Mi sembra a volte che queste due vie d’accesso all’erotismo siano quelle dominanti semplicemente perché, ognuna a suo modo, ci tengono al riparo dall’angoscia di incontrare davvero un altro essere umano, e noi stessi, per ciò che siamo: un corpo.
Come nel caso dell’incontro col morto – con il suo mix di tenerezza, comicità e angoscia – anche gli incontri occasionali estivi ti sbattono in un di fuori, ti riportano in superficie, sul limite dei corpi e dei pezzi di corpo che, troppo spesso – fuori dalle due logiche menzionate – finiamo per avvertire, con disagio e inquietudine, come pura carne da macello. L’estate (o per lo meno ciò che io associo a questa parola) è anche un’altra esperienza del corpo, del corpo riscoperto come superficie, come oggetto plastico e plasmabile che io sono negli altri, e che gli altri sono in me. L’estate è una gioia, una festa dei corpi, che si atteggiano, si tendono, brillano, provocano ognuno sul limite – al contempo angosciante e ridicolo – di se stesso: quello in cui sono bocca, labbra, muscoli tesi, sguardo e oggetto guardato, sudore che cola come un olio.
Le notti d’estate, le notti di festa, sono forse – insieme al carnevale – una delle poche sopravvivenze genuinamente dionisiache della nostra cultura. Nella festa dell’estate l’aria e la musica si fondono, orge di sguardi e persone si frugano voracemente, come manichini senza nome in attesa di essere chiamati alla vita da un profumo, da un cenno d’intesa, da un sorriso.
Nella festa ogni differenza si azzera, si rovescia, si estingue, tutto evapora in superficie: l’individuo, quello del calcolo, dell’individualismo e dell’utile – quello che il giorno dopo si sveglierà per andare a lavorare, o che, in un post-sbronza colossale, si lascerà sommergere da una marea di angosce riguardanti il proprio futuro – è sospeso, essudato nel turbinio della festa.
Il lavoro non è la festa
Dopo la festa le giornate in torretta non hanno nulla da invidiare ai più celebri supplizi o martirii: il mare, che sta sempre dentro e fuori, si trasforma in un magma da cui colano i mostri peggiori della mente. Ma il gioco vale la candela, perché quelle giornate di pura agonia servono per ricordare, per marchiare a fuoco, che il lavoro non è la festa: che si lavora per vivere, e non viceversa; che il lavoro non è l’essenza dell’uomo, per lo meno non nel senso disgustoso e grottesco in cui queste parole di Marx sono state scempiate dall’ideologia neoliberale. Quando Marx ha detto che il lavoro è l’essenza dell’uomo intendeva dire che, essenzialmente, l’uomo e la sua storia sono questo fare, questo dispendio di energie, questo essere insieme: una pulsione indistruttibile alla trasformazione del mondo, di se stessi e degli altri.
“Il lavoro non è la festa” significa che non è nel lavoro che bisogna cercare la felicità, né la propria identità, bensì in tutto ciò che lo trascende: nella famiglia – per cui si lavora, negli amici – con cui si lavora e si fa la festa, nella festa stessa – che in fondo non è altro che lo sperpero gioioso, e comune, dei frutti del lavoro e delle energie “eccessive” che il lavoro non può assorbire. Queste “energie” sono le energie sociali, relazionali, erotiche: le energie propriamente umane. Sono queste energie che potrebbero e dovrebbero, come un ritorno di fiamma, reiniettarsi nel lavoro e nel mondo del lavoro, semmai volessimo davvero provare – ognuno nel suo piccolo – a trasformarlo dal di dentro: provare a trasformare la concorrenza spietata e la guerra tra poveri in una vera amicizia e in un’intima complicità; provare a trasformare l’autoimprenditorialità in un gioioso, goduto e comune naufragio verso un “peggio” che potrebbe rovesciarsi in un “meglio”; verso un abbassamento di aspettative, o una perdita di prestigio sociale, in cui potremmo riscoprire la forza e la voglia di ridere masochisticamente insieme.
L’ultima volta che ho avuto la possibilità di fare un piccolo ciclo di seminari all’università avevo proposto ai ragazzi un corso di Michel Foucault (le “Lezioni sulla volontà di sapere”), allora appena uscito in francese, in cui il filosofo, un po’ a bruciapelo, scrive in una nota che il “masochista” non è chi trova il proprio piacere nella sofferenza, o nel fallimento, bensì qualcuno che – accettando la sfida della verità – intende il dolore e il fallimento, vissuti a livello del corpo e della vita, come una “prova”: una prova di forza che renderà il suo discorso più forte di quello del suo avversario. Anche Nietzsche, nella “Volontà di potenza”, era giunto alla paradossale conclusione che esistono due forme di “masochismo”, una negativa e una positiva: da una parte il dio in croce, una maledizione scagliata sul mondo; dall’altra Dioniso fatto a pezzi, una promessa di vita.
Elastico fecondo
Nell’attesa di scoprire se questo elastico, che per me è stato incredibilmente fecondo, tra ricerca universitaria e vita di stagione potrà continuare, mi sono chiesto spesso se in questa apparente perdita, in questo riso nel naufragio e in questa festa – sempre temuti e osteggiati dalla logica utilitaria del capitale – non si celi una chance per riscoprire un “noi” in cui, davvero, tutti gli sfruttati – dagli stagionali ai giovani ricercatori – possano riconoscersi; un “noi” che possa prendere a funzionare come un cancro, come un bug, nel discorso dominante dell’autoimprenditorialità che ormai intacca trasversalmente ogni classe sociale e ogni ambito lavorativo.
L’unica certezza è che i Lucrezi di oggi si sbagliano: il loro riso è un riso solitario, privato, invidioso, perdente; perché in fondo solo quando si è naufraghi, solo quando si è insieme, si può ridere di quel riso di cui – in altri tempi – si è detto che un giorno seppellirà i padroni.
Nel frattempo è giunta la sera, domani si ricomincia, aspettando che arrivino l’aria fresca di fine settembre, e il cielo enorme spazzato dal vento, a lasciarmi spaesato nelle mattine dei primi giorni in cui sarò finalmente “libero”; quei giorni in cui, istintivamente, appena sveglio, avrò l’impulso di dirigermi automaticamente verso la spiaggia per prendere il mio posto, come se fossi parte della sua fauna, un elemento del paesaggio, uno dei tanti granelli di sabbia con cui ho imparato a confondermi. Forse, in altri tempi, o in un altro paese, il mio posto sarebbe stato altrove, e chissà forse un giorno lo sarà anche qui. Quello che credo di aver capito in questi anni, però, è che ciò che conta davvero – proprio come per il masochista di Foucault – è che la mia vita sia all’altezza delle mie parole.
Fonte L’Espresso
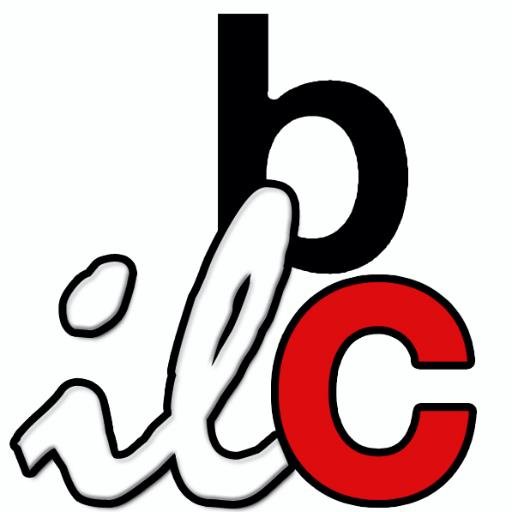
Redazione1592 Posts











0 Comments