Il “messaggio” non è più quello di una volta
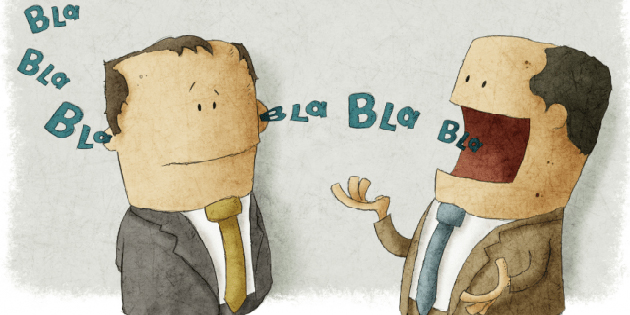
Magari, qualcuno di voi si domanderà in base a quale criterio scelgo una parola piuttosto che un’altra, e quindi come mai tra le innumerevoli parole della lingua italiana, nel caso specifico, ho scelto proprio il vocabolo “messaggio”.
Sarò schietta, la motivazione principale è molto semplice.
“Messaggio”, è un termine che amo molto, ma che al tempo stesso mi crea un leggero “fastidio”. Sì, “fastidio”. E questo poiché mi sono resa conto che più diventa semplice comunicare a distanza (tramite la tecnologia), più la “distanza” diventa, per così dire, il terzo incomodo delle relazioni umane.
Per dare vita ad una qualunque forma di messaggio è necessario che ci siano due figure principali, un mittente ed almeno un destinatario (del messaggio). Assodato ciò, quando “il terzo incomodo” su citato può diventare un vero problema? Quando ci accorgiamo che, ad esempio, con una naturalezza quasi sconcertante si scrivono delle parole forti, importanti ad una persona, ma che poi non siamo in grado di pronunciarle a voce. E’ evidente che il nostro modo di comunicare e di rapportarci all’altro si è “abituato” con troppa facilità al non vis-à-vis e quindi, di conseguenza, tutto o quasi diventa semplice da scrivere, ma difficile da dire.
Come ho già anticipato, “messaggio” è una parola che amo anche, e molto.
Lo trovo un termine con un accentuata nota romantica, soprattutto se torno con la mente a racconti, storie dove si narra di biglietti in bottiglia ritrovati dopo tanti anni. Oppure a storie dove tra i protagonisti principali c’erano anche dei piccioni viaggiatori che facevano da tramite tra amanti segreti o politicanti corrotti. Un termine che ha il potere di farmi tornare a quando ero una bambina di circa 8 anni, a quando mi trovavo in campagna e volavo sull’altalena costruita da mio nonno. Di fronte a me, imponente, si mostrava il paesaggio rupestre e faceva capolino il paese di San Giovanni in Galdo con il suo campanile. Un giorno la mia attenzione fu richiamata non dal classico suono delle campane, ma dalla voce di un uomo che pronunciava parole in dialetto.
Incuriosita, domandai a mio nonno chi fosse quell’uomo e perché gridasse al punto da sentirlo fino a Toro. Mio nonno mi spiegò che si trattava di una figura denominata “u band” che aveva ricoperto un ruolo molto importante soprattutto nel passato, nella quotidianità di una comunità. Si diceva così tra i paesani: “mò pass quill du band!” In termini più moderni potremmo definirlo un dispensatore di messaggi che contenevano informazioni di vario genere come, ad esempio, il fatto che in piazza si sarebbe tenuto un comizio politico, la chiusura della condotta idrica o la presenza in paese di alcuni commercianti come i venditori di sarde, di sedie, del fabbro, ecc.
Sarebbe bello se, in ognuno di noi, vivesse idealmente “u band”. Ci spronerebbe a preferire non dico sempre, ma più spesso, il suono della nostra voce.

Maria Elena Francalancia21 Posts
Nata a Cortona nel 1981, si diploma presso l'istituto tecnico commerciale L.Pilla di Campobasso. Successivamente si trasferisce a Roma per intraprendere la carriera universitaria dove studia tre anni presso l'Accademia di belle arti. Ad oggi sono tre le esposizioni che ha tenuto: Reasia, Reasia #2 e Gessetti. Nel dicembre 2013 consegue la laurea in Scienze della comunicazione presso l'università degli studi del Molise, discutendo la tesi in storia dell'arte contemporanea, intitolata: "La pittura dell'immaginario: visionari e Metafisici, da Bocklin al Surrealismo".











0 Comments